|
|
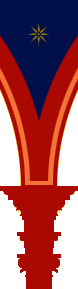 |
 |
| |
 |
Roberto Di Ceglie (1)
Senso Comune e Verità
INDRODUZIONE.
REALISMO E SENSO COMUNE
PER UN RECUPERO CRITICO DELLA VERITÀ.
Saggio uscito su Senso Comune e Verità. Verso un fondamento comune
alle diverse formulazioni di verità,
a cura di Roberto Di Ceglie;
saggi di Roberto Di Ceglie, Philip Larrey, Antonio Livi, Gaspare Mura, Dario Sacchi, Horst Seidl, Editrice EDIVI Edit. del Verbo
Incarnato, 2004.
|
 |
|
 Si lamenta spesso una
perdita di attenzione da parte del nostro tempo per il tema della verità. Uno scetticismo diffuso ne avrebbe relegato
nell’insignificanza la pur fondamentale e ineludibile esigenza. Il che appare di eccezionale gravità se si tiene
presente che la verità non è solo oggetto di riflessioni dotte; essa è prima ancora quel carattere del
discorso di tutti gli uomini (dotti e non) sulla base del quale essi conoscono la realtà che li circonda e ne decidono
giorno per giorno le conseguenti condotte pratiche. Ma la verità può apparire delegittimata solo a livello esplicito,
perché implicitamente, costitutivamente, chiunque ne ha bisogno. Insomma, il problema della verità si evidenzia
quanto alle formulazioni della sua nozione, e quindi le difficoltà che la riguardano emergono laddove essa è considerata
come oggetto di riflessione filosofica (o generalmente « scientifica ») e non come oggetto di conoscenza
comune. Se è difatti indubbio che la cultura contemporanea risente di un cospicuo disinteresse nei confronti del tema
della verità, è altrettanto evidente che nessuno può né pensare né vivere senza riferimento
ad essa. [...] Si lamenta spesso una
perdita di attenzione da parte del nostro tempo per il tema della verità. Uno scetticismo diffuso ne avrebbe relegato
nell’insignificanza la pur fondamentale e ineludibile esigenza. Il che appare di eccezionale gravità se si tiene
presente che la verità non è solo oggetto di riflessioni dotte; essa è prima ancora quel carattere del
discorso di tutti gli uomini (dotti e non) sulla base del quale essi conoscono la realtà che li circonda e ne decidono
giorno per giorno le conseguenti condotte pratiche. Ma la verità può apparire delegittimata solo a livello esplicito,
perché implicitamente, costitutivamente, chiunque ne ha bisogno. Insomma, il problema della verità si evidenzia
quanto alle formulazioni della sua nozione, e quindi le difficoltà che la riguardano emergono laddove essa è considerata
come oggetto di riflessione filosofica (o generalmente « scientifica ») e non come oggetto di conoscenza
comune. Se è difatti indubbio che la cultura contemporanea risente di un cospicuo disinteresse nei confronti del tema
della verità, è altrettanto evidente che nessuno può né pensare né vivere senza riferimento
ad essa. [...]
 Si tratta certamente
di un paradosso, che risalta peraltro anche attraverso un’altra considerazione. Quando si affronta la questione della
verità nell’attuale contesto culturale, non emerge solo – come per altri temi di discussione – il problema
della sua definizione, bensì anche quello dell’effettiva opportunità di porla a tema: è il caso di
occuparsene? o non si tratta di una questione priva di interesse (perché l’oggetto sarebbe scontato) o addirittura
di significato (perché l’oggetto sarebbe inesistente)? Queste due posizioni potrebbero essere assunte come
emblematiche degli atteggiamenti più diffusi che parte dell’Occidente moderno ha generato quanto al tema della
verità. Da un lato – secondo i portati di certo razionalismo che riduce la conoscenza a « copia »
mentale di qualcosa di esterno – essa sarebbe un’ovvia (e quindi scontata) corrispondenza tra pensiero e cose; dall’altro
– in base Si tratta certamente
di un paradosso, che risalta peraltro anche attraverso un’altra considerazione. Quando si affronta la questione della
verità nell’attuale contesto culturale, non emerge solo – come per altri temi di discussione – il problema
della sua definizione, bensì anche quello dell’effettiva opportunità di porla a tema: è il caso di
occuparsene? o non si tratta di una questione priva di interesse (perché l’oggetto sarebbe scontato) o addirittura
di significato (perché l’oggetto sarebbe inesistente)? Queste due posizioni potrebbero essere assunte come
emblematiche degli atteggiamenti più diffusi che parte dell’Occidente moderno ha generato quanto al tema della
verità. Da un lato – secondo i portati di certo razionalismo che riduce la conoscenza a « copia »
mentale di qualcosa di esterno – essa sarebbe un’ovvia (e quindi scontata) corrispondenza tra pensiero e cose; dall’altro
– in base
a uno scetticismo relativistico sempre più pervasivo – non bisognerebbe
neanche più nominarla, perché inesistente o – più correttamente – impossibile da conseguire,
come cioè se di nulla di ciò che si dice o si pensa si potesse dire che è vero o falso. E
queste stesse categorie del resto perdono di significato alla luce di entrambe le prospettive appena accennate.[...]
 Nel primo caso –
la verità come « copia »– si potrebbe escludere a priori la possibilità dell’errore
o il carattere progressivo della conoscenza; ma soprattutto risulterebbe che ogni giudizio in merito, ossia sul carattere di
copia della verità, andrebbe senz’altro accettato, appunto come copia, e dunque non sarebbe concepibile
dubitare di tale sua identità, mentre è ovvio che così non è. Nel secondo caso – la verità
impossibile da cogliere – bisogna sottolineare una contraddizione ancor più evidente (lo si è fatto sin
dall’antichità), per cui se non è possibile accettare come vero alcun giudizio, risulta altrettanto
impossibile asserire questo stesso giudizio come vero. E da qui deriva che l’atteggiamento scettico e relativistico
non gode di alcun fondamento teoretico, poiché per essere affermato e sostenuto deve rinnegare il proprio nucleo speculativo
di fondo, ossia il « rifiuto sistematico della verità come possibilità del pensiero ».1
[A. LIVI, Le forme attuali del relativismo, in R. DI CEGLIE (a cura di), Pluralismo contro relativismo.
Filosofia, religione, politica, Edizioni Ares, Milano 2004, p. 36.] Nel primo caso –
la verità come « copia »– si potrebbe escludere a priori la possibilità dell’errore
o il carattere progressivo della conoscenza; ma soprattutto risulterebbe che ogni giudizio in merito, ossia sul carattere di
copia della verità, andrebbe senz’altro accettato, appunto come copia, e dunque non sarebbe concepibile
dubitare di tale sua identità, mentre è ovvio che così non è. Nel secondo caso – la verità
impossibile da cogliere – bisogna sottolineare una contraddizione ancor più evidente (lo si è fatto sin
dall’antichità), per cui se non è possibile accettare come vero alcun giudizio, risulta altrettanto
impossibile asserire questo stesso giudizio come vero. E da qui deriva che l’atteggiamento scettico e relativistico
non gode di alcun fondamento teoretico, poiché per essere affermato e sostenuto deve rinnegare il proprio nucleo speculativo
di fondo, ossia il « rifiuto sistematico della verità come possibilità del pensiero ».1
[A. LIVI, Le forme attuali del relativismo, in R. DI CEGLIE (a cura di), Pluralismo contro relativismo.
Filosofia, religione, politica, Edizioni Ares, Milano 2004, p. 36.]
 La verità si mostra
in tal modo come ineludibile carattere del discorso, e afferma inoltre la propria identità di relazione tra pensiero
ed essere e di « adeguazione » del primo al secondo. Difatti, ciascuno dei giudizi sottesi ai due atteggiamenti
appena richiamati evidenziache per essere giudicato vero o falso necessita di un confronto tra quanto afferma e le cose alle
quali si riferisce; e si ricava inoltre con la medesima evidenza che il giudizio di verità o falsità dipende dalla
sua capacità di adeguarsi alla realtà di quelle cose .2 [Si
veda R. DI CEGLIE, La formulazione tommasiana della verità come « adaequatio rei et intellectus », in questo
volume.] Allo stesso modo, qualsiasi definizione della verità necessita che la sua formulazione venga giudicata
più o meno rispondente ad essa, quindi vera oppure falsa a seconda che il giudizio in questione si adegui oppure
no alla sua realtà. Insomma è la riconduzione (elenchica) all’evidenza, propria della conoscenza
comune e universale (alla quale ci riferiremo a breve con l’espressione più adeguata « senso comune
»), a sostenere innanzitutto la definizione della verità che la tradizione filosofica ha elaborato ed espresso
una volta per tutte nella formulazione di Tommaso d’Aquino – adaequatio rei et intellectus – e a permettere
di rilevare che di essa è impossibile fare a meno « anche soltanto per un attimo ».3
[V. POSSENTI, La domanda sulla verità e i suoi concetti, in ID. (a cura di), La questione
della verità. Filosofia, scienze, teologia, Armando, Roma 2003, p. 22.] La verità si mostra
in tal modo come ineludibile carattere del discorso, e afferma inoltre la propria identità di relazione tra pensiero
ed essere e di « adeguazione » del primo al secondo. Difatti, ciascuno dei giudizi sottesi ai due atteggiamenti
appena richiamati evidenziache per essere giudicato vero o falso necessita di un confronto tra quanto afferma e le cose alle
quali si riferisce; e si ricava inoltre con la medesima evidenza che il giudizio di verità o falsità dipende dalla
sua capacità di adeguarsi alla realtà di quelle cose .2 [Si
veda R. DI CEGLIE, La formulazione tommasiana della verità come « adaequatio rei et intellectus », in questo
volume.] Allo stesso modo, qualsiasi definizione della verità necessita che la sua formulazione venga giudicata
più o meno rispondente ad essa, quindi vera oppure falsa a seconda che il giudizio in questione si adegui oppure
no alla sua realtà. Insomma è la riconduzione (elenchica) all’evidenza, propria della conoscenza
comune e universale (alla quale ci riferiremo a breve con l’espressione più adeguata « senso comune
»), a sostenere innanzitutto la definizione della verità che la tradizione filosofica ha elaborato ed espresso
una volta per tutte nella formulazione di Tommaso d’Aquino – adaequatio rei et intellectus – e a permettere
di rilevare che di essa è impossibile fare a meno « anche soltanto per un attimo ».3
[V. POSSENTI, La domanda sulla verità e i suoi concetti, in ID. (a cura di), La questione
della verità. Filosofia, scienze, teologia, Armando, Roma 2003, p. 22.]
 [...] Per sottolineare
che questa definizione non è costruzione intellettuale che poco ha a che vedere con le stringenti evidenze appena richiamate,
è forse il caso di ricordare che essa fa tutt’uno col realismo gnoseologico classico il cui carattere di fondo
coincide proprio con quanto quelle evidenze mostrano: che le cose esistono indipendentemente dall’intelletto, e che quindi
questo deve adeguarsi ad esse, o – per dirla con Étienne Gilson – che è la conoscenza a essere
giudicata a partire dalle cose, non il contrario . 4 [Cfr É. GILSON, Réalisme
thomiste et critique de la connaissance, Vrin, Parigi 1939, p. 182. Di particolare incisività in merito risultano
nel corso di questo volume le pagine di D. SACCHI, Genesi e trasfigurazione della nozione moderna di verità. Razionalismo
e idealismo di fronte al realismo antico-medioevale.] Si noti che le nozioni di verità e di realismo, così
come quella di « senso comune » – che definiremo più avanti, ma che per intanto abbiamo già
identificato con certezze che si sostanziano di evidenza, spontaneità e universalità –, risultano sin da
ora in una stretta connessione, per cui nessuna di esse pare poter fare a meno delle altre. Tra le tante conferme che potremmo
richiamare a sostegno di questa affermazione, va ricordato che non casualmente lo stesso termine « realismus »
risulta assente dal lessico filosofico medioevale, ossia dal contesto che per antonomasia ne ha elaborato il sistema gnoseologico
corrispondente (ivi compresa la formulazione della verità come adaequatio rei et intellectus); e ancor di più,
sul piano dei contenuti della riflessione del tempo, risulta assente la dialettica realismo/idealismo: essa (e quindi anche
l’uso del termine « realismo ») sarebbe intervenuta solo nell’epoca moderna, sulla scia
del cogito cartesiano. Si evince dunque il carattere di implicitezza, di spontaneità – e di conseguenza
di universalità – che necessariamente va riconosciuto all’elaborazione del realismo classico: non come teoria
costituitasi nel distacco dall’esperienza diretta e non mediata delle cose, ma come prosecuzione spontanea sul piano dell’elaborazione
riflessa e filosofica di quanto l’esperienza comune e universale suggerisce con evidenza indiscutibile al sapere degli
uomini. Non a caso il fondamentale elemento critico assunto dalla filosofia moderna è stato generato dal cogito
summenzionato (volo dubitare de omnibus) che risulta del tutto incompatibile con la predisposizione immediata di ogni
uomo nei confronti dell’evidenza dell’esistenza di sé e del mondo che lo circonda. E non è casuale
neanche che prima della cruciale riflessione di Descartes una simile impostazione critica risulti totalmente assente, e che
proprio presso un autentico gigante della gnoseologia di tutti i tempi quale Tommaso d’Aquino risulti altrettanto assente
la critica della conoscenza come disciplina filosofica a sé stante. [...] [...] Per sottolineare
che questa definizione non è costruzione intellettuale che poco ha a che vedere con le stringenti evidenze appena richiamate,
è forse il caso di ricordare che essa fa tutt’uno col realismo gnoseologico classico il cui carattere di fondo
coincide proprio con quanto quelle evidenze mostrano: che le cose esistono indipendentemente dall’intelletto, e che quindi
questo deve adeguarsi ad esse, o – per dirla con Étienne Gilson – che è la conoscenza a essere
giudicata a partire dalle cose, non il contrario . 4 [Cfr É. GILSON, Réalisme
thomiste et critique de la connaissance, Vrin, Parigi 1939, p. 182. Di particolare incisività in merito risultano
nel corso di questo volume le pagine di D. SACCHI, Genesi e trasfigurazione della nozione moderna di verità. Razionalismo
e idealismo di fronte al realismo antico-medioevale.] Si noti che le nozioni di verità e di realismo, così
come quella di « senso comune » – che definiremo più avanti, ma che per intanto abbiamo già
identificato con certezze che si sostanziano di evidenza, spontaneità e universalità –, risultano sin da
ora in una stretta connessione, per cui nessuna di esse pare poter fare a meno delle altre. Tra le tante conferme che potremmo
richiamare a sostegno di questa affermazione, va ricordato che non casualmente lo stesso termine « realismus »
risulta assente dal lessico filosofico medioevale, ossia dal contesto che per antonomasia ne ha elaborato il sistema gnoseologico
corrispondente (ivi compresa la formulazione della verità come adaequatio rei et intellectus); e ancor di più,
sul piano dei contenuti della riflessione del tempo, risulta assente la dialettica realismo/idealismo: essa (e quindi anche
l’uso del termine « realismo ») sarebbe intervenuta solo nell’epoca moderna, sulla scia
del cogito cartesiano. Si evince dunque il carattere di implicitezza, di spontaneità – e di conseguenza
di universalità – che necessariamente va riconosciuto all’elaborazione del realismo classico: non come teoria
costituitasi nel distacco dall’esperienza diretta e non mediata delle cose, ma come prosecuzione spontanea sul piano dell’elaborazione
riflessa e filosofica di quanto l’esperienza comune e universale suggerisce con evidenza indiscutibile al sapere degli
uomini. Non a caso il fondamentale elemento critico assunto dalla filosofia moderna è stato generato dal cogito
summenzionato (volo dubitare de omnibus) che risulta del tutto incompatibile con la predisposizione immediata di ogni
uomo nei confronti dell’evidenza dell’esistenza di sé e del mondo che lo circonda. E non è casuale
neanche che prima della cruciale riflessione di Descartes una simile impostazione critica risulti totalmente assente, e che
proprio presso un autentico gigante della gnoseologia di tutti i tempi quale Tommaso d’Aquino risulti altrettanto assente
la critica della conoscenza come disciplina filosofica a sé stante. [...]
 È dunque la modernità,
o meglio quella parte di essa che inizia col dubbio metodico di Descartes (non spontaneo ma volontario, e quindi non universale)
e che prosegue sulla sua scia (da Kant all’idealismo e oltre), a produrre il rifiuto del realismo e della verità
come adaequatio, dando vita a quell’« immanentismo » in reazione al quale Jacobi coniò
il termine « realismo », e che alla continuità della riflessione filosofica con l’esperienza
diretta e immediata delle prime evidenze circa l’esistenza delle cose e dell’io che è tipica di quest’ultimo,
oppone il carattere volontaristico dell’« opzione » del dubbio universale. 5
[Si veda in merito C. CARDONA, Metafisica dell’opzione intellettuale, trad. it. Edizioni Università
della Santa Croce, Roma 2003.] Per contrastare tale immanentismo, i fautori del realismo (Reid e Vico, come anche Fénelon,
Buffier e altri) fecero uso della nozione di « senso comune » (« sensus communis
», « sens commun », « common sense »), forse con l’intento
di richiamare, più che a dotte diatribe sul piano gnoseologico, alla disarmante evidenza delle conseguenze contraddittorie
implicate dalla sua negazione. Nell’opera qui già citata e dal significativo titolo di Réalisme thomiste
et critique de la connaissance (1939) Gilson, al quale non casualmente si deve buona parte dell’effettiva ricomprensione
novecentesca della portata speculativa della filosofia tommasiana, avrebbe ricostruito la storia di quei tentativi. Giova forse
in tal senso richiamare un esempio che in linea con essa lo stesso filosofo francese avanza. Si tratta della distinzione tra
sensazioni di cose realmente esistenti e allucinazioni: come distinguere le une dalle altre con certezza? In realtà,
scrive Gilson, « le difficoltà incominciano solamente quando il filosofo intraprende l’opera
di trasformare questa certezza sensibile in una certezza di natura dimostrativa che sia l’opera dell’intelletto.
È allora che nascono le obiezioni idealiste classiche contro la validità della testimonianza dei sensi ».
6 [É. GILSON, Réalisme thomiste et critique de la connaissance,
cit., p. 197.] La dimostrazione dunque non è necessaria, ma è voluta dalla decisione
di qualcuno, e stride violentemente con l’evidenza che è di per sé sufficiente per distinguere e riconoscere
le allucinazioni come tali. Del resto, se « le nostre sensazioni non si distinguono intrinsecamente dalle
nostre immagini per un qualche segno sicuro, come possiamo noi, non dico risolvere il problema, ma almeno porlo? ».
7 [Ibid., p. 122.] [...] È dunque la modernità,
o meglio quella parte di essa che inizia col dubbio metodico di Descartes (non spontaneo ma volontario, e quindi non universale)
e che prosegue sulla sua scia (da Kant all’idealismo e oltre), a produrre il rifiuto del realismo e della verità
come adaequatio, dando vita a quell’« immanentismo » in reazione al quale Jacobi coniò
il termine « realismo », e che alla continuità della riflessione filosofica con l’esperienza
diretta e immediata delle prime evidenze circa l’esistenza delle cose e dell’io che è tipica di quest’ultimo,
oppone il carattere volontaristico dell’« opzione » del dubbio universale. 5
[Si veda in merito C. CARDONA, Metafisica dell’opzione intellettuale, trad. it. Edizioni Università
della Santa Croce, Roma 2003.] Per contrastare tale immanentismo, i fautori del realismo (Reid e Vico, come anche Fénelon,
Buffier e altri) fecero uso della nozione di « senso comune » (« sensus communis
», « sens commun », « common sense »), forse con l’intento
di richiamare, più che a dotte diatribe sul piano gnoseologico, alla disarmante evidenza delle conseguenze contraddittorie
implicate dalla sua negazione. Nell’opera qui già citata e dal significativo titolo di Réalisme thomiste
et critique de la connaissance (1939) Gilson, al quale non casualmente si deve buona parte dell’effettiva ricomprensione
novecentesca della portata speculativa della filosofia tommasiana, avrebbe ricostruito la storia di quei tentativi. Giova forse
in tal senso richiamare un esempio che in linea con essa lo stesso filosofo francese avanza. Si tratta della distinzione tra
sensazioni di cose realmente esistenti e allucinazioni: come distinguere le une dalle altre con certezza? In realtà,
scrive Gilson, « le difficoltà incominciano solamente quando il filosofo intraprende l’opera
di trasformare questa certezza sensibile in una certezza di natura dimostrativa che sia l’opera dell’intelletto.
È allora che nascono le obiezioni idealiste classiche contro la validità della testimonianza dei sensi ».
6 [É. GILSON, Réalisme thomiste et critique de la connaissance,
cit., p. 197.] La dimostrazione dunque non è necessaria, ma è voluta dalla decisione
di qualcuno, e stride violentemente con l’evidenza che è di per sé sufficiente per distinguere e riconoscere
le allucinazioni come tali. Del resto, se « le nostre sensazioni non si distinguono intrinsecamente dalle
nostre immagini per un qualche segno sicuro, come possiamo noi, non dico risolvere il problema, ma almeno porlo? ».
7 [Ibid., p. 122.] [...]
 Gilson registrò
anche le manchevolezze dell’uso settecentesco e ottocentesco della nozione di « senso comune
». Le attribuì soprattutto all’assenza di un’organica riflessione in grado di controbattere i tentativi
razionalistici di respingere le certezze di senso comune nella sfera dell’irrazionale. 8
[Ci si permetta in merito un rinvio a R. DI CEGLIE, Étienne Gilson. Filosofia e Rivelazione,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004, pp. 103-129.] E così un allievo del filosofo francese, Antonio Livi,
conscio dell’importanza di questa nozione per un’adeguata ricomprensione del realismo e della quaestio de veritate,
si è accinto alla sua definizione formale attraverso un’approfondita elaborazione storiografica e teoretica . 9
[Cfr di lui Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Edizioni Ares, Milano 1990;
Il senso comune tra razionalismo e scetticismo. Vico, Reid, Jacobi, Moore, Massimo, Milano 1992; Il principio di coerenza.
Senso comune e logica epistemica, Armando, Roma 1997; Verità del pensiero. Fondamenti di logica aletica, Lateran
University Press, Città del Vaticano 2002; La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Casa
editrice Leonardo da Vinci, Roma 20032.] Ne è derivata un’elaborazione del « senso
comune »come di un « sistema organico-genetico di giudizi spontanei e necessari
dell’intelligenza umana » ; 10 [A. LIVI, Filosofia del senso
comune, cit., p. 7.] ciò dal punto di vista formale, mentre sul piano dei contenuti si tratta delle certezze
relative all’esistenza del mondo, dell’io, della libertà e della responsabilità morale, del fondamento
ultimo o Dio. È un « sistema organico » a causa dell’impossibilità
di negarne anche solo un elemento; è « genetico » perché ognuno
di essi, nell’ordine in cui sono stati appena citati, deriva da quelli che lo precedono. E, come già abbiamo sottolineato
in precedenza, si tratta di giudizi « spontanei e necessari », ossia « giudizi
di evidenza immediata e giudizi di evidenza mediata (formulati al termine di un’inferenza, cioè un raziocinio,
sia pure spontaneo) » . 11 [Ibid., p. 33. Va precisato che il
tipo di raziocinio cui si fa qui riferimento, e che caratterizza non solo l’inferenza che fa risalire al Principio di
tutte le cose (ultima certezza nell’ordine con le quali le abbiamo elencate) ma anche quello per cui da ogni certezza
del senso comune si passa a quella successiva nell’ordine sopra presentato, non è da intendere nel senso del raziocinio
di tipo scientifico, come Livi stesso sottolinea quando fa riferimento alla spontaneità di tale inferenza. Egli spiega
ciò in tal modo: « non ogni riflessione è scienza, come nemmeno è scienza ogni inferenza; solo
la riflessione e l’inferenza che esigono consapevolezza critica e un metodo rigoroso costituiscono – assieme ad
altre convenzioni stabilite dalla comunità scientifica – la scienza propriamente detta » (Ibid.,
p. 45).] Le certezze in questione sono date, prevengono cioè ogni riflessione, che anzi solo sulla loro base e
a partire da esse può iniziare; se ne può prendere coscienza critica e se ne possono anche tentare definizioni
ma sempre a seguito della loro esperienza. [...] Gilson registrò
anche le manchevolezze dell’uso settecentesco e ottocentesco della nozione di « senso comune
». Le attribuì soprattutto all’assenza di un’organica riflessione in grado di controbattere i tentativi
razionalistici di respingere le certezze di senso comune nella sfera dell’irrazionale. 8
[Ci si permetta in merito un rinvio a R. DI CEGLIE, Étienne Gilson. Filosofia e Rivelazione,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004, pp. 103-129.] E così un allievo del filosofo francese, Antonio Livi,
conscio dell’importanza di questa nozione per un’adeguata ricomprensione del realismo e della quaestio de veritate,
si è accinto alla sua definizione formale attraverso un’approfondita elaborazione storiografica e teoretica . 9
[Cfr di lui Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Edizioni Ares, Milano 1990;
Il senso comune tra razionalismo e scetticismo. Vico, Reid, Jacobi, Moore, Massimo, Milano 1992; Il principio di coerenza.
Senso comune e logica epistemica, Armando, Roma 1997; Verità del pensiero. Fondamenti di logica aletica, Lateran
University Press, Città del Vaticano 2002; La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Casa
editrice Leonardo da Vinci, Roma 20032.] Ne è derivata un’elaborazione del « senso
comune »come di un « sistema organico-genetico di giudizi spontanei e necessari
dell’intelligenza umana » ; 10 [A. LIVI, Filosofia del senso
comune, cit., p. 7.] ciò dal punto di vista formale, mentre sul piano dei contenuti si tratta delle certezze
relative all’esistenza del mondo, dell’io, della libertà e della responsabilità morale, del fondamento
ultimo o Dio. È un « sistema organico » a causa dell’impossibilità
di negarne anche solo un elemento; è « genetico » perché ognuno
di essi, nell’ordine in cui sono stati appena citati, deriva da quelli che lo precedono. E, come già abbiamo sottolineato
in precedenza, si tratta di giudizi « spontanei e necessari », ossia « giudizi
di evidenza immediata e giudizi di evidenza mediata (formulati al termine di un’inferenza, cioè un raziocinio,
sia pure spontaneo) » . 11 [Ibid., p. 33. Va precisato che il
tipo di raziocinio cui si fa qui riferimento, e che caratterizza non solo l’inferenza che fa risalire al Principio di
tutte le cose (ultima certezza nell’ordine con le quali le abbiamo elencate) ma anche quello per cui da ogni certezza
del senso comune si passa a quella successiva nell’ordine sopra presentato, non è da intendere nel senso del raziocinio
di tipo scientifico, come Livi stesso sottolinea quando fa riferimento alla spontaneità di tale inferenza. Egli spiega
ciò in tal modo: « non ogni riflessione è scienza, come nemmeno è scienza ogni inferenza; solo
la riflessione e l’inferenza che esigono consapevolezza critica e un metodo rigoroso costituiscono – assieme ad
altre convenzioni stabilite dalla comunità scientifica – la scienza propriamente detta » (Ibid.,
p. 45).] Le certezze in questione sono date, prevengono cioè ogni riflessione, che anzi solo sulla loro base e
a partire da esse può iniziare; se ne può prendere coscienza critica e se ne possono anche tentare definizioni
ma sempre a seguito della loro esperienza. [...]
 Non è certo questa
introduzione la sede idonea per discutere la teoria del « senso comune » elaborata da
Livi con la profondità che essa sibili obiezioni alla sua presunta irrazionalità o ingenuità, che tuttora
alcuni continuano ad addebitarle, non sempre sostenuti dal doveroso vaglio della sua struttura. 12
[Come scrive Dario Sacchi, è forse il caso di chiedersi se, paradossalmente, « una completa
e rigorosa giustificazione delle certezze del senso comune non sia qualcosa di accessibile solo a una prospettiva filosofica
così matura ed elevata, [… ] da risultare ostica anche per non pochi pensatori di professione » (D. SACCHI,
Oggettività e finitezza del conoscere umano. Premesse teoriche per un pluralismo non relativistico, in R. DI CEGLIE
[a cura di], Pluralismo contro relativismo, cit., p. 64).] Molti inoltre risultano vittime della confusione tra
l’espressione « senso comune » (che Livi, sulla scorta della sua stessa storia,
ha ripensato come insieme di cognizioni universali, spontanee e irriflesse) e quelle di « buon
senso » (che è saggezza pratica) e di « conoscenza ordinaria »
(che è nozione forse di ordine più sociologico che filosofico, e che indica un vasto insieme di cognizioni di
base, perlopiù variabili a seconda dei contesti culturali di appartenenza). [...] Non è certo questa
introduzione la sede idonea per discutere la teoria del « senso comune » elaborata da
Livi con la profondità che essa sibili obiezioni alla sua presunta irrazionalità o ingenuità, che tuttora
alcuni continuano ad addebitarle, non sempre sostenuti dal doveroso vaglio della sua struttura. 12
[Come scrive Dario Sacchi, è forse il caso di chiedersi se, paradossalmente, « una completa
e rigorosa giustificazione delle certezze del senso comune non sia qualcosa di accessibile solo a una prospettiva filosofica
così matura ed elevata, [… ] da risultare ostica anche per non pochi pensatori di professione » (D. SACCHI,
Oggettività e finitezza del conoscere umano. Premesse teoriche per un pluralismo non relativistico, in R. DI CEGLIE
[a cura di], Pluralismo contro relativismo, cit., p. 64).] Molti inoltre risultano vittime della confusione tra
l’espressione « senso comune » (che Livi, sulla scorta della sua stessa storia,
ha ripensato come insieme di cognizioni universali, spontanee e irriflesse) e quelle di « buon
senso » (che è saggezza pratica) e di « conoscenza ordinaria »
(che è nozione forse di ordine più sociologico che filosofico, e che indica un vasto insieme di cognizioni di
base, perlopiù variabili a seconda dei contesti culturali di appartenenza). [...]
 Ma ciò che è
davvero determinante per la trattazione che qui introduciamo, è che i rilievi avanzati sinora ci paiono condurre felicemente
alla tesi di fondo sostenuta in questo libro: in primo luogo, e soprattutto, che l’attuale ricomprensione del valore del
realismo gnoseologico passa attraverso una rigorosa definizione di ciò che è « senso
comune », poiché contro l’immanentismo moderno è apparso necessario esplicitare quanto il realismo
classico non aveva mai avuto bisogno di tematizzare: il valore razionale delle indeducibili e indimostrabili certezze
universali, spontanee e necessarie (prima di tutte: res sunt) sulla base delle quali ogni scienza si edifica; in secondo
luogo, e di conseguenza, che si può così liberare la verità dalle riduzioni alle quali è stata sottoposta
a partire dal fraintendimento anti-realistico della nozione di adaequatio rei et intellectus. 13
[Si vedano in merito i saggi dedicati in questo volume da R. DI CEGLIE a La formulazione tommasiana della
verità come « adaequatio rei et intellectus », da H. SEIDL a La concezione platonica della verità
nell’interpretazione di Heidegger, da D. SACCHI alla Genesi e trasfigurazione della nozione moderna di verità.
Razionalismo e idealismo di fronte al realismo antico-medioevale.] Questo libro intende dunque recuperare il nesso
tra la nozione di senso comune e quella di verità, nella convinzione che, se è vero che la formulazione realista
dell’adaequatio sottende le altre possibili definizioni della verità (come si è mostrato in precedenza,
ogni possibile giudizio sulla loro verità o falsua difesa non può che passare – così come è
avvenuto storicamente – attraverso la rigorizzazione della nozione di « senso comune
» .14 [Si spiegano così il titolo e il sottotitolo del presente
volume così come la sua articolazione interna, che si sostanzia di vari saggi dedicati alla formulazione della verità
presso alcuni tra i più significativi indirizzi filosofici della classicità e della modernità, e di un
saggio finale che tenta di confrontarne gli esiti alla luce della teoria del senso comune qui adottata. Dei saggi che costituiscono
il volume, frutto di attività di studio promosse dall’Associazione Internazionale di Filosofia "Sensus communis"
di Roma, quello di Dario Sacchi è già apparso, con altro titolo (cfr nota 12) e con significative integrazioni
in R. DI CEGLIE (a cura di), Pluralismo contro relativismo, cit., pp. 63-84.] Ma ciò che è
davvero determinante per la trattazione che qui introduciamo, è che i rilievi avanzati sinora ci paiono condurre felicemente
alla tesi di fondo sostenuta in questo libro: in primo luogo, e soprattutto, che l’attuale ricomprensione del valore del
realismo gnoseologico passa attraverso una rigorosa definizione di ciò che è « senso
comune », poiché contro l’immanentismo moderno è apparso necessario esplicitare quanto il realismo
classico non aveva mai avuto bisogno di tematizzare: il valore razionale delle indeducibili e indimostrabili certezze
universali, spontanee e necessarie (prima di tutte: res sunt) sulla base delle quali ogni scienza si edifica; in secondo
luogo, e di conseguenza, che si può così liberare la verità dalle riduzioni alle quali è stata sottoposta
a partire dal fraintendimento anti-realistico della nozione di adaequatio rei et intellectus. 13
[Si vedano in merito i saggi dedicati in questo volume da R. DI CEGLIE a La formulazione tommasiana della
verità come « adaequatio rei et intellectus », da H. SEIDL a La concezione platonica della verità
nell’interpretazione di Heidegger, da D. SACCHI alla Genesi e trasfigurazione della nozione moderna di verità.
Razionalismo e idealismo di fronte al realismo antico-medioevale.] Questo libro intende dunque recuperare il nesso
tra la nozione di senso comune e quella di verità, nella convinzione che, se è vero che la formulazione realista
dell’adaequatio sottende le altre possibili definizioni della verità (come si è mostrato in precedenza,
ogni possibile giudizio sulla loro verità o falsua difesa non può che passare – così come è
avvenuto storicamente – attraverso la rigorizzazione della nozione di « senso comune
» .14 [Si spiegano così il titolo e il sottotitolo del presente
volume così come la sua articolazione interna, che si sostanzia di vari saggi dedicati alla formulazione della verità
presso alcuni tra i più significativi indirizzi filosofici della classicità e della modernità, e di un
saggio finale che tenta di confrontarne gli esiti alla luce della teoria del senso comune qui adottata. Dei saggi che costituiscono
il volume, frutto di attività di studio promosse dall’Associazione Internazionale di Filosofia "Sensus communis"
di Roma, quello di Dario Sacchi è già apparso, con altro titolo (cfr nota 12) e con significative integrazioni
in R. DI CEGLIE (a cura di), Pluralismo contro relativismo, cit., pp. 63-84.]
|
 (1).
Docente di Filosofia della storia nell’Università Lateranense e di Storia della filosofia morale nell’Università
di Bologna (Polo di Rimini). (1).
Docente di Filosofia della storia nell’Università Lateranense e di Storia della filosofia morale nell’Università
di Bologna (Polo di Rimini).
|
|
* * *
(Pagina protetta dai diritti editoriali.)
* * *
Inizio pagina |
|
HOMEPAGE · CONVIVIUM · ACÙLEUS · HORTUS · GYMNASIUM
ROMANO AMERIO · EIKÒNA · THESAURUS · CALENDARIUM
|
|
|
 |